Le ultime tre sontate al Festival MiTo nell’esecuzione di Filippo Gamba
L’arte di Filippo Gamba si colloca da sempre su binari che sembrano correre paralleli rispetto alle strade battute; rotte appartate, sentieri impervi concessi a chi ha il fiato lungo e non disdegna la fatica. Sì, la fatica: dai percorsi d’ascolto che il pianista veronese ama disegnare si esce puntualmente stremati, vinti ed avvinti da una tensione narrativa aggrappata sulla nuda parete rocciosa dove rari sono gli appigli. Appuntamento inserito nel cartellone milanese di MiTo, l’omaggio al compleanno di Beethoven offerto lo scorso 8 settembre dall’interprete che nel suo superbo palmares vanta la vittoria al Concorso Géza Anda di Zurigo non poteva essere più dichiaratamente esplicito: tutte d’un fiato, le ultime tre Sonate, contrappuntate da due miniature novecentesche – il Ravel di début de siècle ed il Benjamin degli anni ‘60 – incastonate al loro interno. Quasi un manifesto politico per un interprete che quando siede al pianoforte sembra immediatamente esplorare la cordiera per cercare nella materia la sua sublimazione poetica, distillata da una strumentalità contenuta nelle ferree briglie di un rigore assoluto.
All’uditorio, distribuito secondo le norme anti Covid negli ampi spazi del Teatro dal Verme, bastava l’incipit dell’op. 109, il suo affettuoso incedere incerto e sottilmente incalzante al tempo, per dare la misura di un disegno la cui arcata era già stata gettata: un canto sul fiato, plastico e minuzioso, pura sostanza immaginifica, plasmata dall’abbraccio di un legato totalizzante. L’equilibrio di una scrittura in cui convivono, in un doloroso corpo a corpo, contrappunto e arabesco, humor e lancinante lirismo, trovava in Gamba – che in questi anni ha più volte compiuto l’impresa di attraversare l’integrale delle 32 Sonate – una coscienza etica, prima ancor che estetica, incapace di compromessi, caparbiamente vòlta a recuperare, inscindibile dalla somma bellezza, la voce di una inscalfibile verità. A maggior ragione per orecchie viziate da esecuzioni scalpitanti (sì, perché qui anche il versante “sportivo” è banco di prova e scivoloso terreno di gioco), i tempi staccati suonavano ampi e meditativi. I tempi del mistico. Anche nel morso velenoso dei secondi movimenti che abitano nelle opp. 109 e 110, era l’imperativo di una volontà incrollabile a vincere sulla tentazione di allentare le briglie, e a conservare, superiore alle umane tempeste del cuore, la dignità del passo.
Un magma che potrebbe seppellire interprete e pubblico con la forza della sua tracimante imponenza, e che solo una regia così addentrata avrebbe saputo domare curvandone la sostanza in pensiero portato alla luce, annunciato con quell’incontrovertibile umiltà che è propria delle epifanie. Il labirinto polifonico annidato in queste creature di frontiera procedeva, lento ma inesorabile, verso la foce del silenzio, svelando così, in un processo di progressiva frantumazione del canto, la sua intenzione prima ed ultima: essere esso stesso aria, luce, spirito. Ci era impossibile non andare con il pensiero all’ultimo Lupu, alle sue rivelazioni srotolate a mezza voce, su uno strumento a cui il sortilegio di una rara ricerca timbrica sembrava levare i martelletti. Ad affiorare dal pianoforte di Gamba, in barba agli insopportabili luoghi comuni duri a morire – dal Beethoven “titanico” al precursore del jazz che spesso ne accompagna il destino – era la voce di un’anima vivida, intenta a fare i conti con il senso del proprio testamento, decisa a riepilogare e a raggrumare in microcosmi conclusi i testamenti ricevuti dal passato, dalle mani di Bach e di Haydn su tutti, e a ripensarne il valore universale da proiettare al cielo, al proprio presente prima ancora che al domani, come stella polare capace di riorientare le rotte quando il mondo si oscura.
Una coscienza vigile e purissima, che nella contemplazione delle radici – che meraviglia, il dipanarsi delle variazioni nell’op. 109 ed, ancor più, nella polverizzazione trasfiguratrice della 111, disegnate con olimpico gusto tardosettecentesco – trovava senso e conforto. Le ultime parole, le ultime note portate a riva dopo una traversata così intensa da attraversare le onde dell’autentico sgomento prima della bonaccia. Niente da aggiungere. Solo il silenzio di una riflessione che continua il suo cammino dentro di noi.
FONTE: OperaTeatro
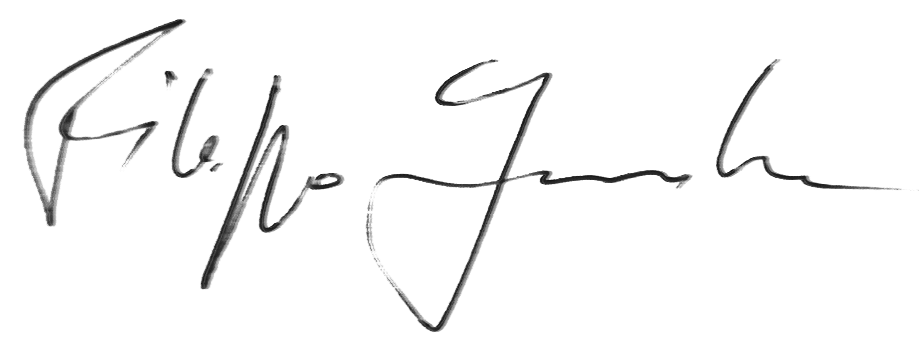


 Deutsch
Deutsch